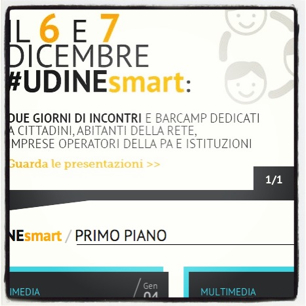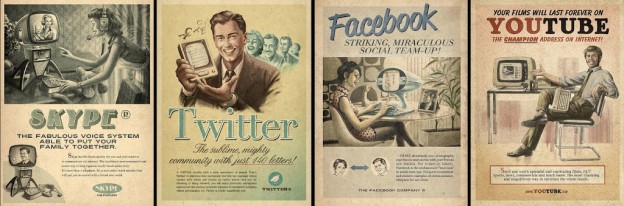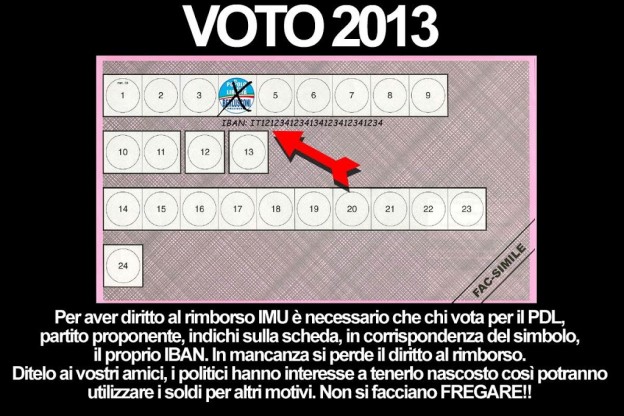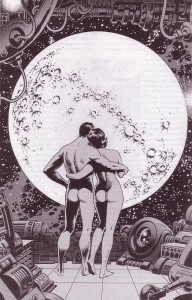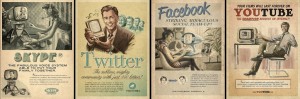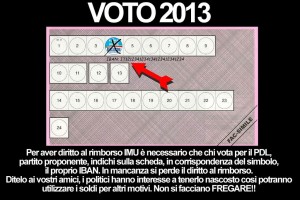Proposta di confronto su un progetto per superare la crisi e creare un’occupazione utile
La crescita è la causa della crisi (potrebbe esserne la soluzione?)
In un sistema economico fondato sulla crescita della produzione di merci la concorrenza costringe le aziende ad aumentare la produttività adottando tecnologie sempre più performanti, che consentono di produrre in una unità di tempo quantità sempre maggiori di merci con un numero sempre minore di addetti. L’effetto congiunto degli aumenti di produttività e della riduzione dell’incidenza del lavoro sul valore aggiunto comporta un progressivo aumento dell’offerta e una progressiva diminuzione della domanda di merci. Nei paesi di più antica industrializzazione questo squilibrio è stato accentuato dalla globalizzazione, che ha permesso alle aziende di delocalizzare le loro produzioni nei paesi dove il costo della mano d’opera è minore, per cui il numero degli occupati in questi paesi è diminuito e nei paesi in cui le delocalizzazioni lo hanno fatto crescere le retribuzioni sono così basse che non compensano la perdita complessiva del potere d’acquisto.
Il debito è l’altra faccia della medaglia della crescita
Lo strumento per compensare lo squilibrio tra incremento dell’offerta e riduzione della domanda insito nelle economie finalizzate alla crescita è stato il ricorso al debito, pubblico e privato, dello Stato e delle sue articolazioni periferiche, delle famiglie e delle aziende. La somma dei debiti pubblici e privati nei paesi industrializzati ha raggiunto circa il 200 per cento del prodotto interno lordo. L’incremento del debito è stato superiore alla crescita del prodotto interno lordo perché sul suo ammontare gravano gli interessi composti e i tassi d’interesse aumentano con l’aumentare del debito. Inoltre la sua espansione non ha limiti se non nell’emissione di carta moneta, la cui convertibilità con l’oro è stata sospesa nel 1971 e dipende soltanto dalla volontà politica, mentre la crescita della produzione di merci trova limiti oggettivi nella disponibilità delle risorse, rinnovabili e non rinnovabili, da trasformare in merci, e nella capacità dei cicli bio-chimici di metabolizzare gli scarti della produzione, che è stata ampiamente superata soprattutto in relazione all’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica da parte della fotosintesi clorofilliana.
Le misure tradizionali di politica economica non funzionano più.
I tentativi di rilanciare la crescita economica effettuati da cinque anni a questa parte non hanno dato i risultati sperati. Secondo la visione ottimistica dell’attuale primo ministro tedesco, signora Merkel, per superare la crisi ne occorreranno almeno altrettanti. Il fatto è che la domanda è sostenuta in maniera determinante dal debito, per cui le misure di politica economica finalizzate a ridurlo deprimono la domanda e aggravano la crisi, mentre le misure finalizzate a rilanciare la domanda attraverso la crescita dei consumi lo accrescono. Per superare questa impasse, senza peraltro ottenere i risultati sperati, le misure di politica economica adottate sino ad ora nei paesi industrializzati sono state finalizzate a:
- ridurre i debiti scaricandone i costi sulle classi sociali meno abbienti e sui ceti medi, mediante drastici tagli alla spesa pubblica per i servizi sociali, riduzioni delle tutele sindacali dei lavoratori, licenziamenti e blocchi delle assunzioni che hanno penalizzato soprattutto le fasce giovanili, inasprimenti della fiscalità indiretta, cessione ai privati della gestione dei beni pubblici
- rilanciare la crescita finanziando col denaro pubblico grandi opere infrastrutturali, realizzabili soltanto da grandi aziende multinazionali.
Inasprimento della lotta di classe dei ricchi contro i poveri.
Questa strategia, peraltro fallimentare, per superare la crisi, è sostenuta da un blocco di potere costituito da tutti i partiti politici, di destra e di sinistra, che hanno la loro matrice culturale nell’ideologia della crescita di derivazione ottocentesca e novecentesca, dalle industrie multinazionali e dalla grande finanza, con un progressivo disprezzo delle regole democratiche a cui pure dicono di ispirarsi. Nei partiti politici di destra e di sinistra, le differenze sui criteri di distribuzione della ricchezza monetaria prodotta dalla crescita della produzione di merci sono sempre meno significative, rispetto alla sostanziale convergenza sulla scelta di scaricare sulle classi popolari e sul ceto medio i costi del rientro dal debito pubblico e di rilanciare la crescita attraverso la mercificazione dei beni comuni e un programma di grandi opere.
Le posizioni neo-keynesiane.
All’interno dell’obbiettivo comune di rilanciare la crescita l’unica differenza politica sulle strategie per raggiungerlo si verifica con alcune frange della sinistra, le correnti new labour e l’estrema sinistra, che sostengono la necessità di
- ridimensionare le misure restrittive finalizzate a ridurre il debito pubblico perché hanno un effetto depressivo e, quindi, in realtà lo aggravano riducendo le entrate fiscali;
- realizzare una più equa redistribuzione del reddito alle classi meno abbienti perché è l’unico modo per rilanciare i consumi;
- aumentare il prelievo fiscale alle classi più ricche per sostenere gli investimenti, con un’attenzione particolare alla cosiddetta green economy;
- incrementare la spesa pubblica per creare occupazione nei servizi sociali a vantaggio delle categorie sociali più deboli.
Un’incredibile rimozione collettiva.
Un’incredibile rimozione collettiva induce i sostenitori della crescita, a qualsiasi corrente di pensiero appartengano, a ignorare i legami delle attività produttive con i contesti ambientali da cui prelevano le risorse da trasformare in merci e in cui scaricano le emissioni dei processi produttivi e gli oggetti che vengono dismessi al termine della loro vita utile. Nella fase storica attuale la crescita non solo è la causa di una crisi economica da cui non ci si può illudere di uscire ripristinando le condizioni precedenti ad essa, perché non può non accentuare progressivamente lo squilibrio tra gli incrementi dell’offerta e la diminuzione della domanda di merci, ma anche di una gravissima crisi ambientale caratterizzata da un prelievo di risorse riproducibili superiore alla loro capacità di rigenerazione annua e da un consumo di risorse non riproducibili che ha ridotto pericolosamente gli stock di alcune di esse, in particolare le fonti fossili, dove il rapporto tra l’energia ricavata e l’energia consumata per ricavarla è crollato (l’e.r.o.e.i., Energy Returned On Energy Invested, del petrolio, che fino al 1940 era superiore a 100, nel 1984 era sceso a 8), mentre al contempo l’aumento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera ha raggiunto una soglia pericolosa per la sopravvivenza stessa della specie umana.
Investire nelle tecnologie che riducono gli sprechi di energia e risorse naturali.
La scelta strategica per uscire dalla crisi aprendo una fase più avanzata nella storia dell’umanità è lo sviluppo delle tecnologie che riducono gli sprechi delle risorse naturali aumentando l’efficienza con cui si usano. Nei paesi industriali avanzati gli usi finali dell’energia sono costituiti al 70 per cento da sprechi. Se la politica industriale venisse finalizzata a ridurli, si aprirebbero ampi spazi per un’occupazione utile, i cui costi sarebbero pagati dai risparmi economici conseguenti ai risparmi energetici senza aggravare i debiti pubblici e privati. Lo sviluppo di queste tecnologie consentirebbe inoltre di attenuare le crisi internazionali per il controllo delle fonti fossili e la crisi climatica causata dalle emissioni di CO2.
La decrescita selettiva della produzione di merci è alternativa sia all’austerità, sia al consumismo irresponsabile.
Il rilancio del consumismo a debito, che comporta un aggravamento della crisi ambientale, non è l’unica alternativa all’austerità, che comporta un aumento della disoccupazione, privando del futuro le giovani generazioni e causando peggioramenti alle condizioni di vita delle classi sociali più deboli. L’austerità non è l’unica alternativa all’aumento del debito pubblico. La decrescita selettiva della produzione di merci, finalizzata alla riduzione del consumo di materia e energia a parità di servizi, è alternativa sia alle politiche di austerità, che aggravano la recessione, sia alle misure espansive di tipo keynesiano basate sul rilancio del consumismo a debito, che mettono in luce solo il collegamento tra più equa redistribuzione della ricchezza monetaria, crescita della domanda e crescita della produzione di merci, ma espungono dal loro orizzonte mentale la correlazione tra l’aumento del debito monetario, finalizzato a rilanciare produzione e consumi, e l’aumento del debito nei confronti della natura che ne consegue.
Una politica economica e industriale finalizzata alla decrescita selettiva della produzione di merci.
La causa scatenante della crisi, a partire dalla crisi dei mutui subprime che le hanno dato avvio nel 2007 negli Stati Uniti, è stato il numero crescente di case invendute. Lo stesso problema è particolarmente acuto in Spagna, in Irlanda, in Italia. Questa situazione per la prima volta dal dopoguerra ha rovesciato uno dei capisaldi dell’ideologia della crescita, sintetizzato in Francia dal detto Quand le bâtiment va, tout va. Oggi l’unico modo di rilanciare il settore dell’edilizia non è la costruzione di nuovi edifici che non troverebbero una domanda, ma la ristrutturazione, principalmente energetica, degli edifici esistenti, affinché riducano almeno di due terzi i loro consumi riducendo le dispersioni termiche. L’unico modo di affrontare la crisi dell’industria automobilistica non è l’illusione di rilanciare la domanda con l’offerta di nuovi modelli, dal momento che dagli anni sessanta ad oggi le automobili circolanti in Italia sono passate da meno di 2 milioni a oltre 35 milioni, ma implementare la produzione di microcogeneratori, che raddoppiano l’efficienza nell’uso dell’energia, ovvero dimezzano i consumi a parità di servizi energetici. L’unico modo di ridurre i costi dei generi alimentari (aumentati del 170 per cento negli ultimi 10 anni a causa dell’aumento dei prezzi delle fonti fossili, che incidono non solo sui trasporti, ma in tutte le fasi produttive dell’agricoltura chimica) è l’incentivazione dell’agricoltura biologica, stagionale, di prossimità, con vendita diretta dai produttori agli acquirenti organizzati nei gruppi d’acquisto solidale, che richiede un maggior numero di occupati, riduce l’impatto ambientale e il consumo di fonti fossili, contribuisce a ridurre i dissesti idrogeologici, ammortizza i maggiori costi di produzione bypassando le intermediazioni commerciali.
Il blocco di potere cementato dall’ideologia della crescita.
La classe dirigente dei paesi industrializzati è composta dall’alleanza strategica tra tre soggetti sociali cementati dall’ideologia della crescita: i partiti politici di destra e di sinistra che hanno le loro radici nella cultura industrialista e produttivista maturata nel corso dell’ottocento e del novecento, le grandi aziende multinazionali prevalse nel corso del novecento dalla competizione con le loro concorrenti, e il comparto specifico dell’alleanza tra questi due soggetti costituito dal complesso politico-militare. Il fulcro su cui questa classe dirigente fa leva per far ripartire la crescita sono le grandi opere pubbliche, che possono essere commissionate solo dallo Stato centrale, o dalle sue articolazioni periferiche, e possono essere realizzate solo da aziende multinazionali. Ma la crescita economica richiede consumi crescenti di energia e materie prime che si possono ottenere solo attraverso il controllo militare delle aree del mondo in cui si trovano. I sistemi d’arma necessari per esercitare questo controllo possono essere commissionati solo dai partiti politici che li ritengono necessari per garantire l’incremento dei consumi energetici, e possono essere prodotti solo da aziende multinazionali. Non a caso le politiche restrittive adottate per ridurre i debiti pubblici non hanno scalfito i privilegi della casta politica, non hanno tagliato i finanziamenti per le grandi opere pubbliche, né le commesse all’industria militare.
Una nuova cultura per una nuova alleanza sociale.
Una politica economica finalizzata alla decrescita selettiva della produzione di merci e del consumo di energia e materia mediante la riduzione degli sprechi, può essere promossa solo da forze politiche non condizionate dai vincoli dell’ideologia della crescita di origine ottocentesca e novecentesca e può essere realizzata solo da piccole aziende, professionisti e artigiani radicati nei territori in cui operano, in grado di effettuare una serie di interventi puntuali, anche di portata limitata. Il settore prioritario in cui occorre intervenire è la riduzione degli sprechi e delle inefficienze negli usi energetici, in particolare negli edifici, che assorbono quasi la metà dei consumi energetici globali e dove si possono ottenere, a parità di benessere, riduzioni superiori al 70 per cento. Una politica industriale finalizzata alla ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio esistente offrirebbe opportunità di lavoro non altrimenti ottenibili a una miriade di operatori del settore e consentirebbe di accrescere l’occupazione in attività qualificate.
Avviare un confronto tra i potenziali sostenitori di un progetto politico finalizzato a superare la crisi mediante una decrescita selettiva della produzione di merci.
Una politica economica e industriale finalizzata alla decrescita selettiva della produzione di merci si può realizzare soltanto se si aggrega un’alleanza di forze politiche, sociali, imprenditoriali e professionali consapevoli del contributo che possono apportarvi con la loro cultura, le loro scelte comportamentali, il loro impegno sociale o ambientale, le loro competenze tecniche, la legittima esigenza di utilizzare a pieno i loro impianti tecnologici per produrre e dare lavoro. I soggetti sociali potenzialmente interessati a collaborare a un progetto di questo genere, sono i seguenti.
1. Le forze politiche non catalogabili negli schieramenti di destra e sinistra in cui si suddividono i partiti accomunati dall’ideologia della crescita, già presenti in alcune istituzioni. Un esempio emblematico si è realizzato nel Comune di Avigliana, in Val di Susa, dove alle elezioni amministrative del 2012 si sono presentate due liste. Una composta dall’alleanza tra il principale partito di centro destra e il principale partito di centro sinistra, accomunati da un programma a favore della realizzazione del treno ad alta velocità con la motivazione che darebbe un impulso alla crescita e all’occupazione.
[1] Nella coalizione antagonista, che ha vinto le elezioni, sono confluiti i rappresentanti dei movimenti contrari al TAV a causa della sua inutilità e dei suoi costi, che proponevano in alternativa di indirizzare gli investimenti sullo sviluppo di attività lavorative a tutela del territorio e a ripristino delle devastazioni che ha già subito. Accanto ad alcune di queste esperienze locali è anche in corso di realizzazione un progetto di aggregazione politica nazionale che sta ricevendo una quantità di consensi superiore a ogni altro partito storico, sebbene la sua fisionomia sia ancora caratterizzata prevalentemente dalla contrapposizione al sistema di potere incarnato da quei partiti più che da un progetto di futuro. Ma le fasi di passaggio di epoca storica non sono mai lineari. I progetti di rottura e ricostruzione si chiariscono progressivamente e solo se sono in grado di catalizzare e far interagire le altre forze che al di fuori delle istituzioni, nei contesti sociali più disparati e nelle attività produttive, realizzano tasselli di un progetto con caratteristiche analoghe.
2. Le piccole aziende e gli artigiani, che attualmente lavorano per lo più nell’indotto delle grandi aziende multinazionali, o come contoterzisti. Costoro non soltanto non vedono valorizzato socialmente il loro ruolo produttivo, ma sono costretti a operare in condizioni sempre più precarie e con utili sempre più ridotti perché in questo modo le aziende multinazionali per cui lavorano riescono ridurre i costi di produzione e sostenere la concorrenza sui mercati globali. La liberazione delle piccole aziende e degli artigiani, che costituiscono il 99 per cento del’industria italiana, da questo ruolo subordinato all’interno dell’economia della crescita può avvenire solo se si ricrea una rete di rapporti commerciali diretti con gli acquirenti che vivono nelle realtà locali in cui esse operano. In questo quadro acquistano un’importanza strategica i professionisti, che costituiscono il canale di comunicazione tra produttori e acquirenti. E un’importanza altrettanto strategica hanno le piccole aziende agricole biologiche di prossimità che sono in grado di garantire la sovranità alimentare a differenza delle grandi aziende multinazionali del settore agro-alimentare, che agiscono sul mercato mondiale e sono del tutto indifferenti alle realtà locali in cui operano.
3. I settori del sindacato che non si sono piegati al ricatto di accettare la riduzione delle tutele, della dignità, della salute e dei salari dei lavoratori per consentire alle aziende multinazionali di sostenere la concorrenza sui mercati mondiali riducendo i costi del lavoro anziché i costi degli sprechi nell’uso delle risorse, o nella patetica illusione di attirare gli investimenti stranieri attualmente indirizzati nei paesi dove il costo della manodopera è molto inferiore, gli orari di lavoro molto più lunghi e non esistono le garanzie conquistare dai lavoratori europei nei decenni passati.
4. Le molteplici forme associative in cui si esprime il bisogno di contribuire al bene comune da parte dei settori più sensibili della popolazione, che non trovano nelle strutture dei partiti esistenti i luoghi in cui esprimere la loro cittadinanza attiva: gruppi di acquisto solidale, banche del tempo, comitati per la tutela del paesaggio, movimenti contro la realizzazione di grandi opere devastanti per i territori in cui abitano, associazioni di volontariato sociale e culturale, associazioni volontarie di comuni impegnati nella tutela del loro territorio e della qualità della vita dei suoi abitanti, gruppi dell’associazionismo cattolico e di altre professioni religiose, aziende operanti nel terzo settore, associazioni ambientaliste e di promozione sociale, comitati di genitori nelle scuole, reti dell’economia solidale e della finanza etica ecc.
Il Movimento per la decrescita felice invita questi soggetti a verificare se, sulla base delle riflessioni qui riassunte, sia possibile realizzare momenti di confronto comuni per collaborare ad affrontare una crisi, che non è solo economica e ambientale, ma una vera e propria crisi di civiltà.
Movimento per la Decrescita Felice