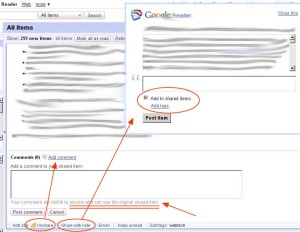Io gli voglio bene, a Umberto Eco.
Mi diede dei bei voti all’università, ci chiacchierai affabilmente un paio di volte passeggiando sotto i portici di Bologna. A imbatterti nei suoi libri di semiotica al momento giusto, quando un amatissimo corso di studi già orienta il tuo sguardo sulle problematiche della significazione e della comunicazione, potrebbero accaderti degli sconvolgimenti radicali, sconquassi cognitivi, e da quel momento in poi ti trovi costretto a leggere il mondo in un certo modo, perché l’eleganza e la potenza di quei metalinguaggi rivelano i meccanismi profondi del nostro dare senso agli eventi, con le parole e con i segni. La semiotica è un punto di vista. Una disciplina, non una scienza. E poi Eco scrive bene, poco da fare, ti fa ridere anche quando ti racconta la filosofia medievale.
Inoltre, non gli si può nemmeno rimproverare di non conoscere i computer, perché saranno almeno quarant’anni che si occupa di logica computazionale e negli anni Sessanta la cibernetica che si intrecciava con la linguistica era dignitosissimo campo di interessi accademici.
Tant’è che da lì sarebbero giunte numerose suggestioni per i linguaggi informatici di programmazione, di cui sicuramente Eco si occupava attivamente tra fine anni ’70 e primi ’80, tra i suoi studi sulle teorie sociologiche della ricezione dell’opera e il successivo interesse per la “lingua perfetta”, naturale o artificiale che fosse, e tutti gli esempi storici che possono venire in mente a essa collegata, da Adamo (in che lingua parlò, quando Dio gli chiese di nominare il Creato?) a Raimondo Lullo a Athanasius Kircher all’esperanto ai linguaggi formalizzati.
Ma di web a quanto pare Eco non ci capisce.
Noi tutti qui ormai traguardiamo i computer e i dispositivi, e puntiamo l’attenzione sulla digital life, sulla socialità in Rete, parliamo di Cultura digitale e non di Cultura informatica. Nel solito parallelo con le strade e le automobili, ci interessiamo dei comportamenti umani negli spazi sociali digitali, non di tecnologia del motore a scoppio (il pc) e della tecnologia della carreggiata autostradale (le reti).
Abbiamo in quindici anni di frequentazione di mondi digitali compreso quanto l’hardware influenzi il software, sappiam fare la tara e applicare le giuste categorie di giudizio valutando a esempio le diverse nicchie ecologiche in cui abitano un blog e un quotidiano online o l’enciclopedia cartacea e wikipedia, conosciamo per esperienza concreta di vita la portata “epistemologica” dei singoli strumenti e ambienti, e soprattutto confidiamo nella conversazione continua e incessante che agisce il web, dove le cose importanti sono i valori in circolazione, la reputazione, la fiducia, il pluralismo delle voci.
Ma di queste cose Eco non sembra accorgersi. Dice che manca il “filtro sociale”, ma la Rete tutta è filtro sociale. Credo per lui il web sia ancora una sorta di biblioteca giusto al di là dello schermo, quella finestra di pixel che io non vedo più.
Lui cerca parole ferme, testi come libri, io guardo i flussi di conversazione e la costruzione sociale della conoscenza e quindi della realtà, cose che peraltro Eco conosce bene, essendo coetaneo di Searle e Fodor, avendo con essi spesso dialogato tramite carteggi e botta-e-risposta nei convegni o nelle prefazioni dei libri, vero Luogo conversazionale dell’epoca dei supporti cartacei, e per aver lui stesso promosso teorizzazioni basate sulla condivisione del valore semiotico dei segni nell’universo dei parlanti (la nozione echiana di “enciclopedia”).
Se Eco vede i blog come libri, forse gli viene in mente una collana, una progressione, una serialità, una linea. E ogni testo è una perla di cui conoscere autore, paratesto, storia editoriale. Ma sono sempre perle in fila.
Per me un blog è un nodo nella Rete, è una parola in un discorso collettivo. Ne valuto la fondatezza e la novità in sé, per quanto posso fare con le mie conoscenze, e poi possiedo strumenti, appresi in anni di frequentazione e di relazioni interpersonali, per misurare nella Rete dei mille intrecci e delle mille voci il valore di quella parola, di quell’articolo giornalistico, di quel post su blog, di quell’affermazione in una chat o su un social network, per come rimbalza, per come viene ripreso e da molti commentato, per le discussioni che riesce a generare nell’ecosistema digitale e poi magari esondare sui media tradizionali, dove spesso viene frainteso in quanto non compreso nel giusto contesto. E il contesto è la chiave interpretativa, sempre.
Dei molti significati di una parola, il contesto seleziona quello pertinente, e la parola assume senso. Qui e ora, storicamente, necessariamente.
Consideriamo dato il valore di uno scritto. Il suo significato storico, contingente, viene da noi misurato secondo relazioni sfondo-figura. La figura, l’elemento figurativo, il segno, trae il suo senso dallo sfondo su cui si staglia. E oggi lo sfondo è cambiato, e non è più fatto di collane secolari di libri che richiamano altri libri, di biblioteche borgesiane o come quelle de “Il Nome della Rosa”, ma è uno spazio vivo, di vive conversazioni.
E la stessa idea di “enciclopedia” di Eco, come cultura che vive nella mente di una comunità di parlanti (e che garantisce il reciproco comprendersi) ha forse cambiato forma, proprio nel senso di “forma del contenuto” su cui Eco rifletteva filosoficamente a fine anni Sessanta, quando stava ancora maturando quelle posizioni che lo avrebbero portato a definire il segno come “funzione segnica” che correla piano dell’espressione e piano del contenuto. E’ cambiata la forma dello sfondo, e dobbiamo modificare il modo in cui attribuiamo senso agli elementi significativi. Oggi la forma dell’enciclopedia è la Rete, non la biblioteca. Già in Eco abbiamo il rizoma quale riferimento figurativo, ma oggi noi tutti abitiamo nello scibile, non solo le opere chiuse (per quanto sempre aperte). Le persone abitano direttamente i Luoghi della conoscenza, e le relazioni tra di loro sono elementi sintattici imprescindibili per la comprensione del testo, della sua semantica misurata nella conversazione.
Con il solito parallelo, potrei anche dire che Eco vede gli alberi, ma non vede il bosco, dove gli alberi vivono come entità collettiva ecosistemica, in dialogo perenne.
Cose magari giuste, ma di quando il web appunto era pensato e vissuto ancora come una biblioteca, fatta di editori/blogger senza alcuna autorevolezza (ma l’autorevolezza se la sarebbero conquistata con le migliaia di interazioni direttamente intrattenute con migliaia o milioni di utenti).
Cose magari giuste, se prese in modo isolato, ma giudicate in un modo terribilmente inadeguato rispetto all’attuale funzionamento dell’ecosistema della conoscenza.
Ragionamenti magari giusti, se intrapresi in solitudine da chi usa il web solo per leggere, senza coinvolgersi personalmente nelle conversazioni su un social network, nei commenti di un blog, in quelle palestre di socialità dentro cui noi ci siamo fatti le ossa, maturando nuove posizioni interpretative e financo etiche sulla portata comunicativa di quanto viene affermato nelle vocianti piazze della Rete, e non solo nei silenti saloni dei conventi del Sapere.
Ahimè, Eco è un tipo unopuntozero.
Poco male, ci penseremo noi a traghettare rispettosamente e creativamente le sue squisite intuizioni sul funzionamento concreto della comunicazione umana nel mondo della Cultura digitale. Un po’ per ciascuno, tutti insieme.
Update: Mantellini approfondisce sul Post