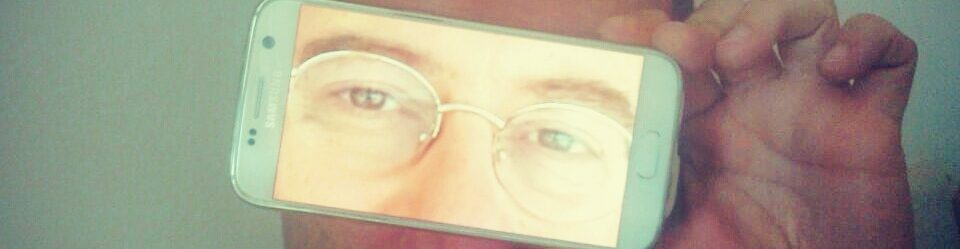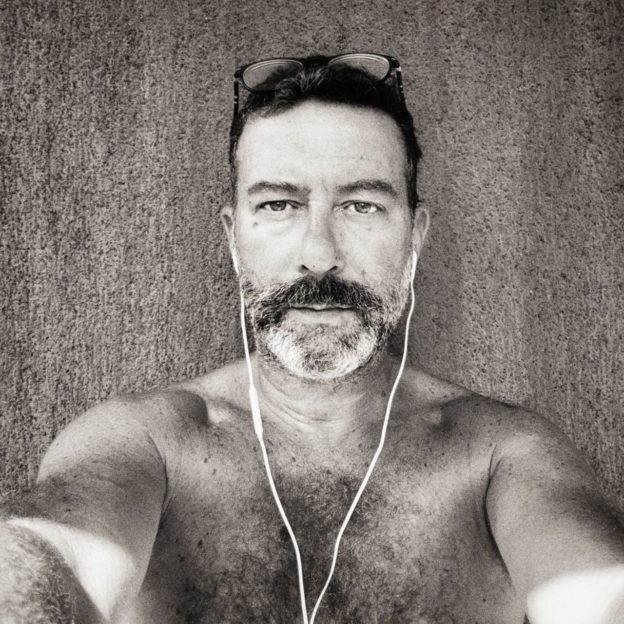[Premessa: questo è un post originariamente scritto su Facebook. Prende le mosse dall’annuncio di un convegno a Trieste promosso per ragionare riguardo gli hatespeech in Rete, sessismo e razzismo. Rifiutando soluzioni tecniche, legislative o buoniste, ho allargato il discorso.]
Ok, Parole O_Stili. A Trieste, 17 e 18 febbraio.
Ci andrò, perché ci saranno amici da salutare. Ci andrò, perché magari qualche ragionamento valevole di attenzione potrebbe saltar fuori. Ci andrò, perché ben venga in ogni forma un’esplicitazione del fenomeno e una presa di coscienza.
Ma qual è il “discorso” del convegno, qual è la filiera? “Ommioddio è oribile” -> “Signora mia dove andremo a finire” -> “Basta, qui bisogna fare qualcosa” -> Leggi liberticide? Il Galateo del XXIsec. con ban e processo incluso? Il Grande Manifesto dell’Italia Migliore per l’Ecologia Buonista della Rete, con la faccia di Boldrini e Mentana? Allora meglio Selvaggia Lucarelli che telefona a casa ai cretini, uno per uno.
Vent’anni fa litigavo e venivo insultato pesantemente sui newsgroup di italianistica, figuriamoci, e stavamo discutendo della [r] polivibrante alveolare, mica di calcio o di vaccini.
Vent’anni fa esatti scrivevo un progetto sulla legge 285/97, la legge Turco sui minori, riguardante la necessaria impellente (ahaha) promozione di una comprensione dei risvolti sociali dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, iniziativa che poi avrei co-coordinato per i successivi tre anni su un intero ambito socio-territoriale lavorando mille ore nelle scuole dell’obbligo, parlando a studenti insegnanti dirigenti e genitori. Pubblicazioni, convegni su convegni, tutti che dicono di sì con la testa e poi prontamente dimenticano, e regalano uno smartphone al figlio in prima media.
Niente di nuovo sotto il sole e sullo schermo, e l’indicazione dell’approccio educativo è rimasto quanto di più vicino sento al mio modo di pensare e agire rispetto al problema. Ma vi ricordate rotten punto com, i vari siti di gore, 4chan, blog orribili? Vi ricordate le reazioni dei politici e dell’opinione pubblica ai bonsai kitten? Avete mai avuto per le mani dieci ragazzini di un istituto professionale nella profonda provincia, e dover essere educatore? Avete mai visto i log dei server scolastici o anche solo la cronologia del browser di un’aula multimediale dieci anni fa, quando ancora non si prendevano provvedimenti tipo blacklist (che ridere) o tracciamenti identificativi? Sapete dove vanno i quindicenni in motorino? Sapete dove vanno i quindicenni in Rete? Sapete distinguere porno sano da porno malato, e quello che pochi anni fa era extreme ora è mainstream? Quali soddisfazioni e quanta autostima può dare blastare la gente, avere l’ultima parola tranciante, insultare pesantemente, discutere per vincere? E sto parlando dei bar, mica solo dei gruppi chiusi di facebook.
Un LOL ci seppellirà, spazzando via secoli di usi e costumi, patine di civiltà, incrostazioni superficiali di galateo, forme di convivenza sedimentate nei rituali sociali, nelle parole ormai inadeguate a veicolare i sentimenti che premono dentro a individui e gruppi sociali, viviamo tutti “fuori dai denti”.
Paura e ignoranza, mancanza di moralità, un’estetica ricalcata su calciatori e veline o personaggi trash del sottobosco mediatico, figure pubbliche lorde di fango, capi di governo impresentabili, assessori arroganti di paesi grandi come due condomini, capiufficio fascisti, meritocrazia calpestata, nessuna prospettiva rincuorante di vita lavorativa, congiuntivi dimenticati e analfabetismo funzionale, giornali quotidiani scandalosi e scandalistici, clickbait forsennato, l’urgenza di trovare un nemico contro cui scagliarsi oppure crearlo bello nuovo ogni giorno, nessuna stella polare su cui orientarsi per costruir sé stessi intorno a un nucleo di dignità… son tutte cose che bruciano bene, la fiamma sotto la pentola a pressione della socialità ora è molto più forte, le valvole cominciano a fischiare. Il magma sotto il vulcano si agita, mille fumarole che si attivano sono sintomo di eruzione esplosiva imminente.
E forse il vulcano, quella crosta solidificata è proprio la forma della civiltà e della convivenza e dello Stato che abbiamo costruito nei secoli, sistemi di premi e punizioni che hanno permesso di ingabbiare e reprimere, reindirizzare le pulsioni, sublimandole grazie a mediazioni, agenti intermedi, patti sociali, sicurezza e sanità e scuole in cambio di tasse, istituzioni come banche e tribunali e carceri e manicomi. È tutto saltato, deal with it.
Uno strano romanzo, una narrazione imprevista, un plot twist, un salto dello squalo nella storia che raccontiamo a noi stessi per definir chi siamo: il protagonista, ovvero la società tutta, d’un tratto si scopre diverso da come pensava di essere, scopre la propria identità essere un camuffamento, c’è uno svelamento e un’agnizione di sé stessi prima letteralmente impensabile, la maschera d’oro cade e mostra la carne, il personaggio nel suo voler-essere congiunto a certi valori apollinei viene sgambettato dal fare concreto, dalle sue stesse azioni dionisiache ebbre e sanguinolente, la nobiltà pretesa viene tradita dal linguaggio plebeo e prevaricatore, la generosità compromessa dal tornaconto personale. La società oggi è *incongruente*, non vi è sintonia tra la testa e la pancia, o meglio tra l’immagine che intendiamo e pensiamo di dare di noi e l’effettivo agire e comunicare, una contraddizione in doppio legame tra quello che affermiamo con le parole e i gesti con cui il corpo mette in scena l’inganno, non potendo nascondere le emozioni.
Per secoli le forme espressive culturali quali la letteratura, la pittura, il teatro hanno messo in scena la nostra interiorità, le regole, i valori in cui volevamo credere, nonché con piccole infrazioni delle regole le “devianze” storicamente necessarie al superamento di paradigmi obsoleti secondo cui intendere il nostro “giusto” stare al mondo come collettività.
Le finte narrazioni del nostro crederci (volerci-credere) animali superiori edulcoravano la realtà spargendo lustrini e autostima, le finte narrazioni del Potere manipolavano gli animi tenendoci dentro uno status quo sempre più gabbia, riconducendo i rivoli della rabbia dentro l’alveo del conformismo e degli schemi capitalistici del “produci consuma crepa”, pane e circo. Ma si tratta di un mondo finto, congelato, dove nulla si muove, dove l’arco della mia esistenza è pre-scritto nella menzogna di una falsa coscienza di cui era facile esserne incoscienti o accettarla come bugia necessaria.
Invece l’azione narrativa o scenica ha bisogno di azione, altrimenti non esiste nessuna storia da raccontare. E i mass-media del Novecento questo volevano, per la loro capacità di raccontare il divenire in tempo reale: volevano eroi contro il sistema. Eroi vincenti, eroi perdenti. Ribelli con o senza motivo, ma che muovessero gli eventi. Tuttavia il sistema era ancora molto intermediato, bisognava ancora imparare un’arte e possedere risorse economiche ingenti per mettere in scena la propria narrazione o dettare l’agenda con il cinema o con la televisione. Ora non più. Con un telefono cellulare ho la potenza mediatica di un tg di dieci anni fa, posso filmare e scrivere e pubblicare in tempo reale su scala planetaria. Ci sono, partecipo, dico la mia.
E dopo il teatro la pittura e la letteratura, facilmente manipolabili e censurabili in quanto dipendenti da sistemi economici di potere per la diffusione delle loro opere, ora abbiamo la Rete.
La Rete è lo specchio dove l’umanità oggi riconosce sé stessa, uno specchio molto meno deformante rispetto ai dispositivi di rappresentazione di sé (individuo e collettività) del passato, il luogo polivocale e immediato dove nessun camuffamento d’identità è possibile come maschera univoca, dove le collettività vedono emergere la propria identità nelle mille facce di cui sono composte e non solo quella messa in scena dai padroni del vapore.
In tal modo prendiamo coscienza di noi stessi, e prendiamo paura, perché non siamo chi pensavamo di essere e chi volevamo essere. L’Eroe ha rotto l’incantesimo, ora può vedere, ma ha perso sé stesso nell’acquisire questa nuova competenza. Non può portare a termine il programma narrativo, non può agire, tutto va rinegoziato, ogni singolo valore ogni tensione e aspirazione.
Siamo dei mostri, e non servirà coprire gli specchi con i lenzuoli.
Ripartire da zero, anzi da uno. Perché ora sappiamo. E anche senza avere ideali irrealistici, possiamo costruire noi stessi su una percezione maggiormente chiara e distinta. Possiamo trasformare l’agire in fare. Il cieco agire in fare consapevole, misurato, responsabile delle conseguenze, attento al contesto. Perché le parole hanno molti significati, il contesto attribuisce il senso.
L’Io della collettività è costituito dall’Io e dalla circostanza della socialità (anche mediatica) che lo contiene, non c’è dentro e non c’è fuori.
Questa mia generazione ha il compito immane di traghettare tutta la propria millenaria Cultura nel Mondo Nuovo, territori che per primi abbiamo esplorato senza mappe, costruendo avamposti. Questo e solo questo possiamo indicare alle prossime generazioni: l’urgenza di progettare modi nuovi di concepire e innervare la socialità dopo il Diluvio digitale, realtà e stili e modi che siano appropriati al loro sentire e desiderio di costruire spazi di civiltà adeguati, secondo visioni e approcci che non ci appartengono, ma dentro cui loro potranno ristabilire i valori di fratellanza e solidarietà e di giustizia e di bellezza, se lo vorranno.