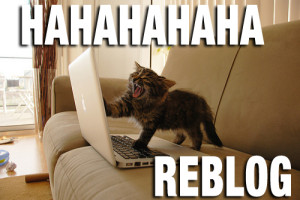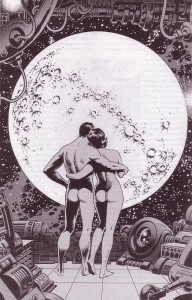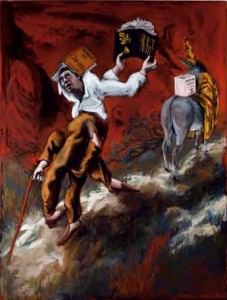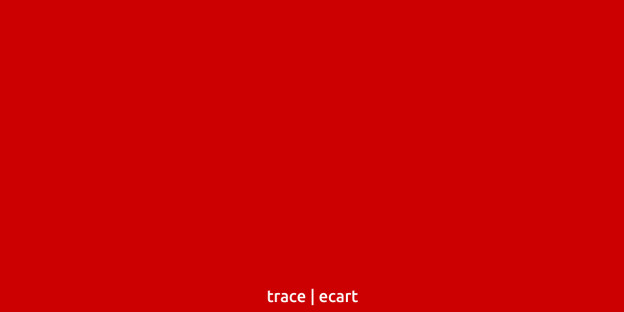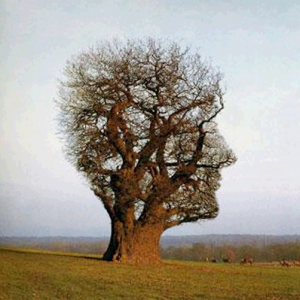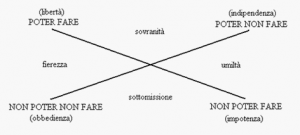Vi mostro un errore.
Un errore di approccio teorico, di inquadramento, di prospettiva, nel porre il problema e quindi nel provare a risolverlo. Perché un problem solving efficace deriva da un problem posing circostanziato.
Noi continuiamo a pensare al futuro come ad una proiezione del passato, mentre la rivoluzione tecnologica ci ha portato dentro un nuovo ecosistema, come diciamo ormai tutti. Abbiam fatto il famoso salto.
La questione più che decennale – o secolare – riguarda la concezione del digitale e delle tecnologie (più o meno nuove) come “strumenti”.
Ripartiamo dal famoso martello: certo che è uno strumento, ma sappiamo che poi tutto quello che vediamo assomiglia a un chiodo, o a qualcosa che può essere colpito.
Perché impugnare un martello modifica la nostra percezione dell’ambiente, la concezione delle funzionalità di questa protesi del nostro braccio e della nostra mano, di noi stessi e del nostro potenziale agire.
Perché anche un martello è una tecnologia abilitante, nel senso che modifica le potenzialità del nostro fare nel mondo (la tecnologia, appunto) e questo è possibile perché trasforma la nostra “postura” mentale, appunto la nostra concezione del mondo.
Questo vale per il martello come per ogni tecnologia e pensiero tecnologico della storia dell’umanità, dal fuoco di Prometeo fino al digitale e alle modificazioni genetiche con CRISPr e al sincrotrone e alla Stazione Spaziale, perché la storia dell’Umanità è sempre la storia tecnologica dell’Umanità, nella profondità dell’evoluzione umana (il fuoco non l’ha “inventato” un sapiens, ricordiamoci), nella tecnologia del linguaggio e nel tramandare generazionalmente le innovazioni del nostro abitare come collettività e comunità, in dialogo perenne con l’ambiente e il territorio da cui trarre risorse e progettare trasformazioni, con uno sguardo capace di leggere (una “grammatica” del paesaggio, dei processi, delle relazioni tra tutti gli attori animati e inanimati) le circostanze e in grado auspicabilmente di prevedere le conseguenze di quelle trasformazioni sull’abitabilità stessa del territorio così modificato.
Bene, abbiamo molte parole chiave.
Strumento, ambiente, linguaggio, tecnologia abilitante, progetto, comunità, dialogo, grammatica territoriale.
Noi abitiamo innanzitutto degli ambienti mentali di organizzazione delle pratiche possibili, delle linee di visione, di opportunità di azione del fare umano. Abitiamo linguaggi, altrettanto notoriamente, e i territori sono conversazioni di un dialogo eterno fra noi e l’ambiente, nei geni e nei memi.
Questo è il punto: se uno strumento è già un ambiente, noi abitiamo linguaggi.
Se i linguaggi sono tecnologia, se le parole che possediamo ci permettono di comprendere e agire nel mondo, di narrarci a noi stessi – e quelle che non possediamo rendono impraticabile un pensiero altro – allora la Tecnologia è la Casa dell’Essere, con formula nota.
La comprensione innanzitutto in noi delle relazioni della nostra mente ed enciclopedia con l’ambiente e la circostanza (l’Io) che ospita la nostra vita rappresenta il Luogo dialogico (non c’è dentro, non c’è fuori, niente dualismo classico, è un continuum, mente e mondo in termini di identità e corrispondenza, “realtà” e rappresentazione) dove emerge il senso dell’Abitare, del trasformare, dell’aver cura. Il nostro EsserCi.
Questo significa senso della frequentazione dei Luoghi indifferentemente fisici o digitali, della partecipazione, delle identità emergenti nel passaggio generazionale, del promuovere il senso dell’abitare nella complessità.
Se continuiamo a concepire il computer o un satellite artificiale o l’automobile o dei pezzi di codice informatico come strumenti, non possiamo (non riusciamo a) cogliere l’ambiente e l’ecosistema in cui questi manufatti vivono inter-relati, il linguaggio con cui denotiamo e connotiamo la loro esistenza come oggetti e soggetti della realtà in una rete sensata di significanti e significati, il nostro stesso collocarci e rapportarci all’esistente.
Costruire il futuro è costruire socialmente, in modo condiviso culturalmente, nell’immaginare il domani.
Costruire futuro significa risemantizzare i luoghi – mentali innanzitutto – che frequentiamo onlife, avendone cura. Il futuro come avvenire, quello su cui posso agire, etimologicamente pro-gettare.
E questo sarà conflitto, tra idee e tra stili dell’abitare, tra generazioni, tra esperti e sviluppatori, e abitanti – unici per i quali fenomenologicamente ha senso il luogo, perché conferiscono senso all’abitare lì e ora.
Significa risemantizzare l’immaginario, la proiezione dei significati, i sogni, i desideri, l’orizzonte della praticabilità.
Lavorare sul contesto, non sul messaggio, per lasciar emergere i nuovi sensi delle nuove situazioni di enunciazione che stiamo vivendo per primi nella storia dell’umanità, dove non si era mai vista una rete planetaria di connessione e una miriade di mondi digitali condivisi, e oggi questo c’è, e noi ci abitiamo creando continuamente valore, urbanistica e comunità, elaborazione corale di una partecipazione e un sentimento di appartenenza alle collettività nostre di riferimento.